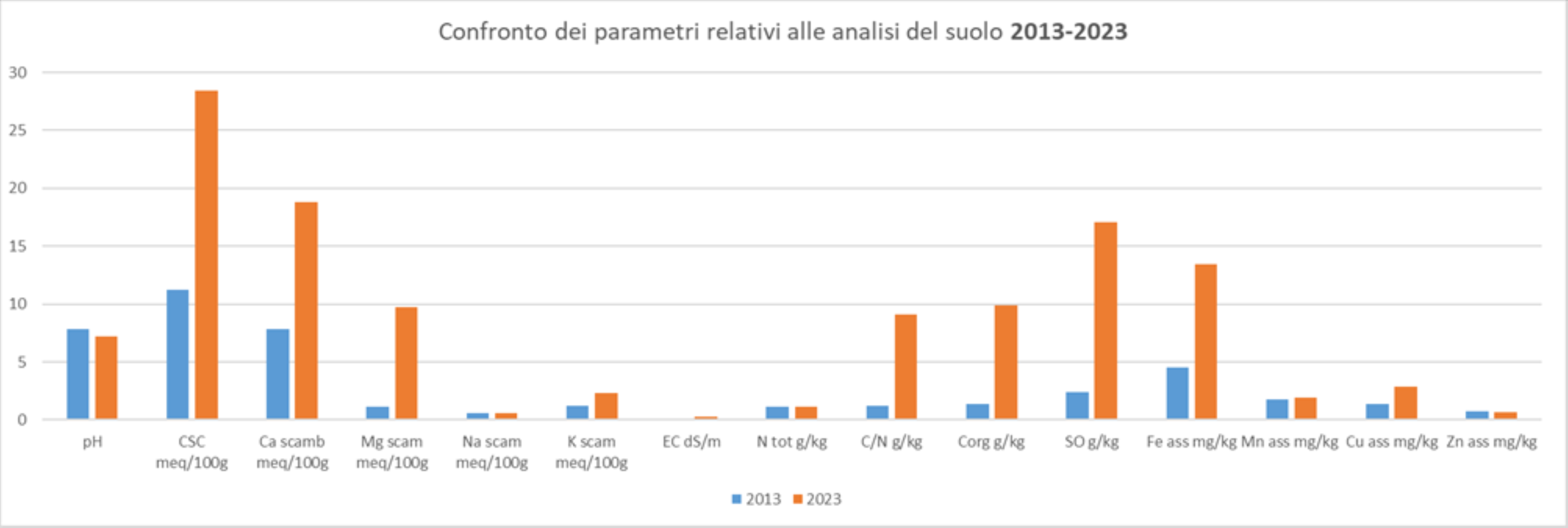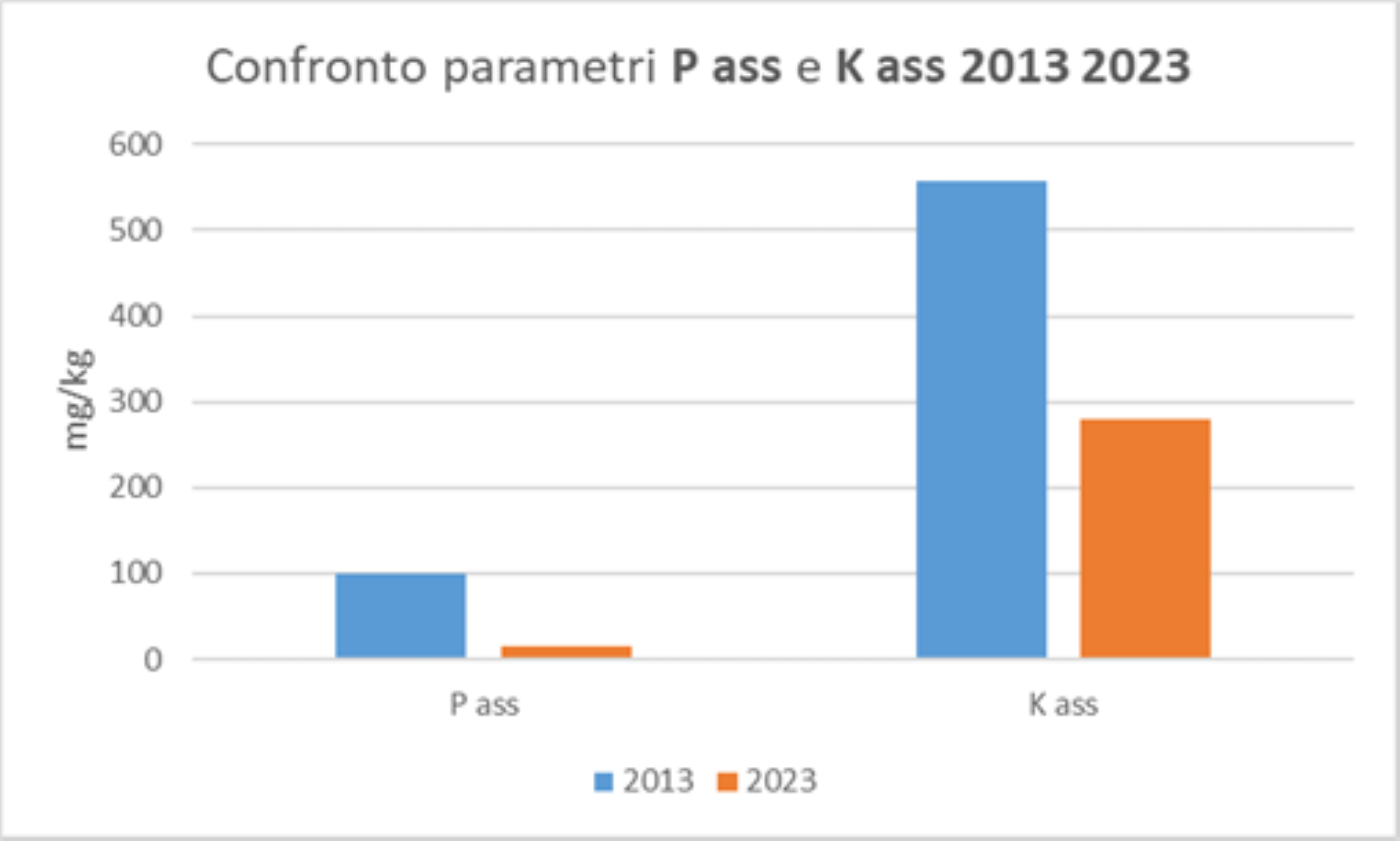Il suolo, per definizione, è lo strato superficiale della crosta terrestre ed è formato da componenti minerali, humus, acqua, aria e organismi viventi. L’eccessivo sfruttamento dei suoli, la monocoltura, pratiche agricole errate portano al depauperamento della matrice organica con conseguenze sulle componenti chimico-fisiche e biologiche.
Il suolo, per definizione, è lo strato superficiale della crosta terrestre ed è formato da componenti minerali, humus, acqua, aria e organismi viventi. L’eccessivo sfruttamento dei suoli, la monocoltura, pratiche agricole errate portano al depauperamento della matrice organica con conseguenze sulle componenti chimico-fisiche e biologiche.
La comunità scientifica ha dimostrato che la natura dell’erosione è spesso associata a pratiche agricole basate sulla lavorazione dei suoli, che nel lungo periodo portano ad una intensa ossigenazione e consequenzialmente ad una più accelerata mineralizzazione della sostanza organica, già carente nei nostri terreni agrari, con maggiore incidenza al Sud Italia.
Inoltre, pratiche volte alla “polverizzazione del suolo”, di cui la fresatura ne è un esempio eclatante (ancora purtroppo praticata in modo errato), o anche grandi eventi piovosi, trasportano masse di strato attivo (il più fertile) verso valle.
A tal proposito, è importante richiamare i concetti di agricoltura conservativa come definita dalla FAO (FAO 2023), ossia, un sistema di coltivazione che promuove il minimo disturbo, mediante il mantenimento di una copertura permanente sul suolo e la diversificazione delle specie. Tale sistema migliora la biodiversità e i processi naturali all’interno e sulla superficie del suolo, contribuendo ad aumentare l’efficienza d’uso dell’acqua, dei nutrienti e una produzione sostenibile migliore.
Le “cover crops” in oliveto
Nelle colture arboree, quindi con un ciclo vitale pluriennale, la situazione ideale per esplicare quanto citato sono le colture di copertura (cover crops), siano esse naturali o artificiali.
Un esempio calzante dell’utilizzo di cover crops sono gli oliveti del bacino del Mediterraneo, i quali spesso sono condotti senza irrigazione, in zone con elevata pendenza, con un terreno agrario già depauperato nella frazione organica.
Le colture di copertura sono tra le pratiche colturali, promosse dalla PAC, che aumentano le funzioni del suolo, proprio per migliorare la sostenibilità di piante perenni tra cui anche l’olivo. Tuttavia, diverse sono le specie che assolvono a tale funzione, i cui effetti sono sconosciuti in termini di qualità del suolo.
Un primo caso di studio
 Arias-Giraldo et al. (2021) hanno studiato gli effetti di quattro differenti gestioni agronomiche sul suolo per una durata di 8 anni, tra cui:
Arias-Giraldo et al. (2021) hanno studiato gli effetti di quattro differenti gestioni agronomiche sul suolo per una durata di 8 anni, tra cui:
a) semina di graminacee,
b) semina con miscuglio con diverse specie,
c) vegetazione spontanea,
d) lavorazioni convenzionali.
I parametri esaminati sono stati l’erosione del suolo e le sue proprietà chimico-fisiche e biologiche. È emerso che la presenza di un cotico temporaneo, messo a confronto con le lavorazioni convenzionali, ha ridotto le perdite di suolo e ha influenzato positivamente le proprietà fisico-chimiche, nonché la diversità microbiologica. Nel caso della semina delle graminacee è stato riscontrato un aumento delle proprietà funzionali del suolo rispetto alle lavorazioni convenzionali che ha comportato, di riflesso, l’aumento e la diversificazione del microbioma rispetto agli altri trattamenti.
L’uso di colture di copertura, oltre ad essere un valido aiuto per la protezione dei suoli, innesca una competizione con le malerbe ottenendo un valido ausilio alla loro gestione. Tuttavia, le conoscenze sugli effetti delle diverse specie sulla soppressione delle infestanti sono ancora limitate, ulteriori studi sono necessari per stabilirne l’efficacia.
In tale senso, risulta efficace un mix di veccia/orzo/pisello sullo sviluppo dell’acetosella gialla (Oxalis pes-caprae) inibendola fortemente, considerando, inoltre, la complessa gestione della stessa anche dopo l’uso di comuni erbicidi (Volakakis N. et al. 2022).
La sperimentazione in oliveto
 Al sud Italia, spesso ci si imbatte in oliveti condotti “in asciutta”, orograficamente svantaggiati e la cui gestione delle malerbe viene ancora condotta mediante operazioni colturali errate (o semplicemente mediante lavorazioni convenzionali), quali la fresatura, pratica notoriamente nata per sminuzzare le zolle e preparare il letto di semina/trapianto. A titolo esemplificativo si ricorda che l’uso della fresatura aumenta la capacità moltiplicativa di numerose specie vegetali che si propagano mediante rizomi (Sorghum spp, Phragmites spp., Cynodon dactylon, ecc.).
Al sud Italia, spesso ci si imbatte in oliveti condotti “in asciutta”, orograficamente svantaggiati e la cui gestione delle malerbe viene ancora condotta mediante operazioni colturali errate (o semplicemente mediante lavorazioni convenzionali), quali la fresatura, pratica notoriamente nata per sminuzzare le zolle e preparare il letto di semina/trapianto. A titolo esemplificativo si ricorda che l’uso della fresatura aumenta la capacità moltiplicativa di numerose specie vegetali che si propagano mediante rizomi (Sorghum spp, Phragmites spp., Cynodon dactylon, ecc.).
Obiettivo di questo articolo è quello di presentare i risultati di 9 anni di inerbimento controllato in un oliveto non irriguo nella provincia di Catanzaro. L’oliveto, cv. Carolea di 50 anni di età, è caratterizzato da sesto di impianto 8 x 8 e gestito da sempre secondo le lavorazioni convenzionali. Dal 2013 si pratica la “non lavorazione”, eseguendo esclusivamente la trinciatura due volte all’anno, includendo anche i residui colturali derivanti dalla potatura biennale dell’arboreto. All’inizio della prova sono state condotte le analisi chimico-fisiche-biologiche di routine per un suolo agrario in modo da avere contezza in fase pre-inerbimento.
Dai risultati ottenuti il suolo dell’oliveto risulta, secondo la classificazione USDA, come “sabbioso”, con un tenore di sostanza organica e carbonio organico scarsi (vedi tab.1), un pH sub-alcalino, una C.S.C. bassa e dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, della valutazione delle caratteristiche esaminate è emerso un rapporto C/N completamente squilibrato, evidenziando una propensione del suolo alla mineralizzazione della sostanza organica.
Per gli anni successivi e fino ad oggi è stata praticata la “non lavorazione” (No-tillage), gestendo il cotico erboso mediante la trinciatura e usando concimi organici ad alto tasso di matrice organica ad anni alterni. Le analisi, condotte alla fine del trial di 9 anni, hanno evidenziato un incremento nei parametri associati alla qualità del suolo rispetto al tempo di partenza, in particolare per quanto riguarda il tenore di sostanza organica (Tab. 1), nel rapporto C/N che da 1,2 è passato a 9,1 e nell’ abbassamento del pH che rientra nella neutralità.
Oltre a ciò, è stato riscontrato un aumento della capacità di scambio cationico riportandola nei parametri di normalità. Nelle figure sottostanti sono messi a confronti i parametri del suolo più rappresentativi nel periodo di riferimento.